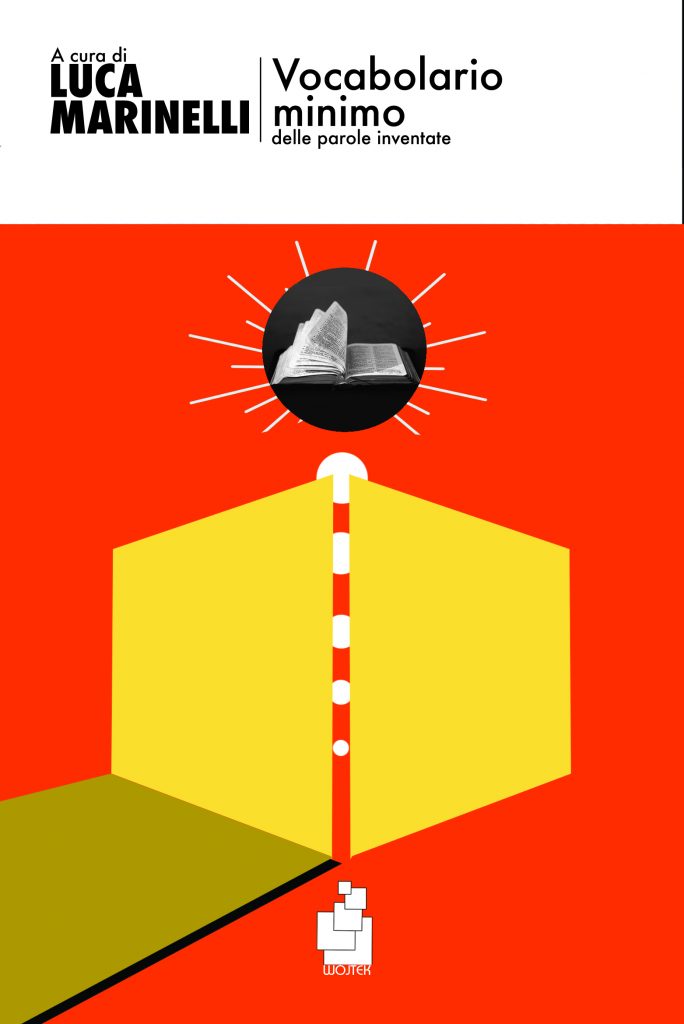 Vocabolario minimo delle parole inventate
Vocabolario minimo delle parole inventate
a cura di Luca Marinelli
Wojtek Edizioni
Di solito le parole sono gli strumenti che gli scrittori usano per creare e animare i loro mondi: mondi ancora inesistenti che si servono di parole esistenti per essere narrati. Nel Vocabolario minimo delle parole inventate è come se questo rapporto si invertisse e i mondi degli scrittori, i loro racconti, diventassero il mezzo per dare vita a nuove parole: parole inventate che si servono di mondi immaginari per essere dette, scritte, narrate. Un esperimento letterario polifonico in cui ventidue scrittori italiani della litweb si confrontano in modo eterogeneo con il racconto di una parola da loro stessi inventata per comporre un nuovo lessico che rende esprimibile ciò che fino a un momento prima è stato inespresso.
Per gentile concessione di casa editrice e autore vi proponiamo la lettura di un ESTRATTO
Wone
Il mondo apparente è l’unico mondo vero – così sembrava a F. quella mattina, senza che questo pensiero affiorasse del tutto alla sua coscienza, mentre bestemmiava la madonna e i santi e lanciava vestiti, libri, fogli sparsi, lenzuola e cartelle a cascata per la stanza. Si trattava di un pensiero impreciso – e in ogni caso l’ordine è l’utopia dell’uomo integro, le chiavi di casa non c’erano. Eppure sono entrato ieri notte, ci sono dentro ora – non sono mica salito dal balcone?
Altre volte era salito dal balcone, dal tetto dell’auto, per grazia di quella sporgenza conica – il canale di scolo delle acque piovane serviva, come una leva, a facilitare ingressi notturni, clandestini, in casa propria: mai confondere origine e scopo di un oggetto – e della portafinestra del balcone appena accostata; altre volte, ma non la notte precedente: aveva bevuto troppo e forse aveva imparato la prudenza. Ricordava la vaga sensazione di rifiuto quando aveva acceso la luce nel pianerottolo: l’idea di incontrare il vicino in il vicino in pantofole – il vecchio insonne, in canottiera e pantaloni a righe, che torturava i listelli di parquet strusciando i piedi, spargendo intorno a sé gli umori del sonno negato, il sudore, l’acidità di stomaco – lo aveva fatto sboccare per terra. Era corso in casa – dunque: aveva aperto la porta – aveva portato fuori un rotolo di carta assorbente e prima aveva raccolto, poi strofinato – aveva avuto, per un attimo, l’idea di sputarci sopra per inumidire – poi si era affrettato dentro e aveva chiuso la porta a doppia mandata. Aveva sciacquato la faccia in cucina, asciugate le mani con uno strofinaccio che avrebbe fatto meglio a lavare due giorni prima, quando il sugo alle acciughe saltando aveva invaso le piastre bollenti – riconosceva un disgusto crescente per ogni residuo organico, non appena questi gli si manifestava davanti: che la morte sia pure, purché non si presenti ai miei occhi. Qualcosa andava storto – che mi succede? Si era spogliato di fretta, soprappensiero, aveva vagato per la camera da letto in cerca di un appiglio – uno scudo, un amuleto –, era rovinato a letto.
Al mattino la sveglia non fece in tempo a suonare, alle cinque e quaranta F. dischiuse le palpebre di colpo, come per un ordine superiore. Il colloquio in agenzia lo disgustava eppure andava fatto, nemmeno cristo e la madonna ci campano a pane e acqua, nemmeno io. Poi la pubblicità, caro mio – se Duchamp, come noi, fosse nato qui, non avrebbe scritto e interpretato la pubblicità di una soda zero calorie, zero zuccheri, zero additivi? Eppure le chiavi non c’erano – di questo si accorse dopo, ormai lavato, vestito, deodorato, prontissimo. Si sentiva eroico, poi il mondo gli ricordò che l’ordine è uno sforzo costante, è una pratica di estenuazione delle variabili aperte, come la virtù e come l’eccellenza. Allora prese a lanciare gli ostacoli che lo separavano dal traguardo agognato – prima con metodo, sollevando appena gli oggetti in gruppi di due o di tre, poi con la furia dell’ultimo uomo, e fu un caricabatterie a soffrire la pena più severa, schiantato al muro, il dente destro spezzato per sempre e una traccia sulla parete come di spari e morti ammazzati. Si sforzò di ripercorrere ogni tappa della notte precedente – un incontro al buio, una scopata furiosa in macchina come da solo con se stesso, un vino bianco troppo fruttato, lo stomaco del vecchio, il mio stomaco, un pianto singhiozzato, il crollo nel sonno – e fu a un passo dalla soluzione ma quel pensiero, nemmeno affiorato del tutto alla coscienza, F. non riuscì ad afferrarlo – se non ci riuscì, è che lo lasciò morire: l’ordine, lo sforzo, la pienezza, la memoria. Alle sette e trenta – secondo i suoi calcoli, avrebbe impiegato alla peggio quarantacinque minuti a percorrere l’intero tragitto, porta a porta, in macchina; alla meglio, traffico e meteo permettendo, trenta o trentuno – decise per l’extrema ratio. Infilò le chiavi della macchina nella tasca della giacca, spalancò la portafinestra del balcone, salì coi piedi sulla ringhiera – era bassa: dopotutto, chiunque può saltare due metri senza spaccarsi le ginocchia, anche io; era bassa e anche, volendo, panoramica: in piedi vedeva, oltre gli alberi, la sagoma della montagna neanche troppo lontana; che aria tersa oggi, si disse, che giornata di merda – e saltò.
L’impatto non fu traumatico, se non per gli orli dei pantaloni stirati di fretta: sotto le scarpe i tessuti in cotone si macchiarono e si strapparono. Guardò la sporgenza conica del balcone, si disse che era un peccato che per salire sì e non per scendere, formulò un pensiero teoricamente rilevante intorno all’inevitabile – alla speranza, all’illusione e all’inevitabile, in una rincorsa circolare, e mai, mai più confondere origine e scopo di un oggetto, di un gesto, di un desiderio: che mi succede? – e lo dimenticò pochi secondi dopo, corse in macchina e mise in moto.
In un angolo della camera da letto, sopra l’armadio, di fianco a una scatola rossa ripiena di reliquie di una persona che l’aveva abbandonato – una lettera, un orecchino di stampo vagamente africano (uno solo), un quaderno dalla copertina in pelle marrone, una matita, uno slip nero, una foto a colori, un ciondolo di bigiotteria e dentro di questo una promessa, scritta a mano, che F. aveva tradito, per quanto si ostinasse a credere che fosse stata lei a non averla mantenuta – posate di lato, wone, le chiavi – in un luogo che è, e che pure, fin quando non si manifesta all’occhio che ostinatamente lo insegue, non esiste.

