Ringrazio il Prof. Guido Carpi per questo interessante e generoso approfondimento offerto a ZEST, e per aver accolto il mio invito a fornire ai nostri lettori una fotografia del panorama letterario russo attuale, risalendo la grande eredità di modelli e pensiero che questa letteratura vanta.
a cura di Antonia Santopietro
Qual è lo stato della letteratura russa attualmente, quali le correnti e gli autori che dobbiamo conoscere?
Così come l’intero corpo sociale del Paese, nel corso degli ultimi trent’anni la letteratura ha subito una lunga serie di traumi che ne hanno duramente segnato gli equilibri e – in una certa misura – anche il livello generale.
Dapprima la Perestrojka di Gorbačëv, che ha prima indebolito e poi abolito la censura, col relativo improvviso ingresso nello spazio culturale di un’enorme mole di testi nazionali e stranieri di ogni fase culturale del Novecento. Sembrerebbe un evento indiscutibilmente positivo, e lo è stato di certo, ma ha anche sconvolto i normali processi evolutivi della letteratura russa, bloccandone lo sviluppo per anni: scrittori e pubblico si sono trovati disorientati, sommersi da tanti capolavori… Chi avrebbe osato debuttare nello stesso numero di rivista che magari ospitava Nabokov o Platonov? Se in un sistema letterario entra “da fuori” un’opera importante, il sistema la ingloba e la “digerisce”, ma se ne entrano contemporaneamente a dozzine, il sistema perde la capacità di metabolizzarle ed esplode.
Nel 1990, per l’ultima volta, è stato compiuto il tentativo di appellarsi a una figura super partes, promuovendo il culto di Solženicyn, ma il nazionalismo messianico e il tradizionalismo ortodosso di cui egli era portatore non soddisfacevano certo tutti: con la fine dell’Urss, la letteratura russa ha perso – né probabilmente recupererà più – la figura dello “scrittore nazionale”. Sono spariti allora altri due fattori molto importanti dell’identità culturale russa: innanzitutto il cosiddetto “litterocentrismo”, per cui la letteratura fungeva anche da sostituta di altre sfere dell’opinione pubblica come la pubblicistica, la sociologia, i dibattiti su questioni d’interesse nazionale; in secondo luogo il messianesimo russo, molto presente in letteratura da Gogol’ fino, appunto, a Solženicyn. La letteratura si è dovuta adattare al ruolo di “letteratura e basta”, espressione dei problemi di un Paese “qualunque”, ormai privo di proiezione universale, ed è stata affrancata dalla censura solo per cadere in meccanismi di mercato anche più brutali che in Occidente.
La letteratura degli anni Novanta ha riflesso bene questo stato di disorientamento. Non che siano mancate opere di valore: penso a Underground di Vladimir Makanin, a Sonja di Ljudmila Ulickaja, alle prime cose di Viktor Pelevin (cito solo opere apparse in lingua italiana). Ma in generale tutto il decennio si è dipanato all’insegna di un postmodernismo molto aggressivo, un continuo gioco alla decostruzione di ogni valore: chi volesse averne un saggio, può recuperare un’antologia di quel periodo, I fiori del male russi, ma il mio entusiasmo per questo épatage autocompiaciuto, lo ripeto, molto modesto. I Duemila e il decennio che si va a chiudere, da questo punto di vista, sono stati più vari, anche se le opere a mio parere di maggior spessore non sono giunte al lettore italiano.
Cosa accade nel mondo editoriale a riguardo degli autori Russi? e cosa è cambiato nel tempo dalle prime traduzioni del secolo scorso quelle di Ripellino di Ginzburg, fino all’età nuova da Gorbaciov in poi?
Bisogna rimanere coi piedi per terra. In Italia, oggi, la letteratura russa è un fenomeno di nicchia, poco promosso dalle case editrici di grosse dimensioni: potrei citare l’edizione delle opere di Sergej Dovlatov da parte di Sellerio, ma è la classica eccezione che conferma la regola, dato che si tratta di uno scrittore di assoluta eccezione, morto però nel 1990. La Russia post-sovietica non riveste certo nell’immaginario del pubblico occidentale quel ruolo che – nel bene e nel male – aveva l’Unione Sovietica, e che rendeva degne d’interesse anche opere letterarie magari di medio livello, ma che narrassero quel mondo (ad esempio lo struggente La casa sul lungofiume di Jurij Trifonov, Editori Riuniti 1997 ma 1° ed. russa 1976), per non parlare di classici assoluti come Il Maestro e Margherita, Il dottor Živago, Requiem, I racconti della Kolyma, Vita e destino, L’Arcipelago GULag, Mosca – Petuški, Fermata nel deserto . Oggi siamo su un altro ordine di grandezza: il lettore lo sa e si orienta altrove, così che di solito le case editrici piccole e medio- piccole pubblicano autori russi contemporanei solo in presenza di un qualche finanziamento da parte di fondi culturali.
Da noi, per un po’, ha prevalso la moda del brutalismo, sia in salsa, ancora una volta, postmodernista (Vladimir Sorokin) che in quella ultranazionalista (Zachar Prilepin) e provincial-minimalista (Roman Sencin). Si tratta di scrittori non privi di talento, ma ormai, nel casellario merceologico del consumo letterario, la Russia ci fornisce solo pulp banditesco a tinte forti, condito di tatuaggi, sparatorie e ammazzasette belli e violenti: ciò anche per effetto di abili operazioni commerciali come il libro di Emmanuel Carrère su Eduard Limonov o le buffe stilizzazioni di Nikolaj Lilin: siccome non bastavano gli scrittori gangster russi originali, abbiamo cominciato a produrceli in casa!
Al di là di questo mainstream muscolare, posso segnalare alcune uscite un po’ atipiche: una buona panoramica sugli scrittori più recenti è l’antologia di racconti Falce senza martello (Stilo, 2017), a cura di Giulia Marcucci; un’altra antologia interessante uscita di recente a cura di Virginia Pili è I quattro anni che cambiarono il mondo (Red Star, 2017), che – in occasione del centenario dalla Rivoluzione – raccoglie corrispondenze e racconti dai fronti della guerra civile russa: non sono certo autori contemporanei, ma riempiono una lacuna nella nostra visione di quegli eventi chiave. Per il resto, sulle uscite più interessanti degli ultimi quindici-vent’anni in Italia (non solo russe, ma slave in genere), si può consultare la documentata rassegna sul portale di letteratura dell’Università di Bologna.
Quanto ai traduttori, oggi ce ne sono di veramente molto bravi (alcuni, lo dico con orgoglio, sono usciti dall’Università di Pisa, dove ho insegnato per più di tre lustri, fino all’anno scorso), ma è giocoforza che lavorino con le commesse che toccano loro: si possono solo sognare il potere di contrattazione con le case editrici che avevano Ripellino o anche colleghi degli anni Settanta (i quali, sia detto, proprio per questo spesso nel tradurre si prendevano qualche libertà di troppo). Certo, alcuni margini di scelta ci sono, né un vero professionista si cimenterebbe con un testo scadente, ma nessuno, oggi, si può permettere di tradurre per amore disinteressato un grande libro, e poi in subordine cercare di pubblicarlo. Se per avventura qualcuno ci volesse provare, gli consiglio senz’altro di tradurre Cala la tenebra sui vecchi gradini di Aleksandr Čudakov (2000): un’epopea familiare che si snoda nel periodo staliniano e oltre. Qui siamo davvero non molto lontani dai livelli della grande letteratura russa, di cui l’autore era del resto un valente studioso. Sinceramente, per anni ho pensato che Cala la tenebra fosse stato il canto del cigno della prosa russa a questi standard, e che con la morte di Čudakov avessimo perso lo stampo per cose del genere, ma giusto recentemente mi sono dovuto ricredere: la quarantacinquenne Marija Stepanova, già nota come poetessa, ha da poco licenziato In memoria della memoria, una recherche sulla storia della propria famiglia, per molti versi affine al capolavoro di Čudakov, anche se la lingua di Stepanova è più impressionistica, più lirica, a tratti, per i miei gusti, un po’ leziosa e autocompiaciuta… Nel mio mondo perfetto, vedrei questi due libri in una bella edizione Einaudi o Adelphi: evidentemente, fra i generi della letteratura russa classica, quello della prosa pseudo-memorialistica (per fare esempi noti: la trilogia autobiografica di Tolstoj, Il salvacondotto di Pasternak, Il rumore del tempo di Mandel’štam) è l’unico a saper offrire ancora opere che non sfigurano troppo accanto ai capolavori del passato; un altro buon esempio recente di romanzo dai risvolti memorialistici – ma con un impianto finzionale più marcato – è Lo zar ha ordinato di impiccarti (2017) della russo-lituana Lena Eltang, che si ispira consapevolmente al Nabokov de Il dono.
A proposito di pia desideria, vedrei bene – per parlare di grandi classici da noi poco letti – un solido doppio Meridiano di Andrej Platonov o uno con una nuova traduzione ben curata e commentata de Il placido Don di Michail Šolochov: ecco cosa andrebbe davvero ritradotto! La saga cosacca di Grigorij Melechov e di Aksin’ja è un grande classico, che a tratti se la batte con Guerra e pace, pur essendo un’epopea “plebea”, certo molto diversa da quella incentrata sul Principe Andrej, Pierre e Nataša; purtroppo è stata tradotta coi piedi, per di più su un’edizione del più buio periodo tardo-staliniano, storpiata dei passi migliori.
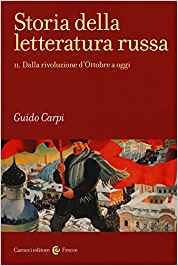 Lei è autore di “Storia della letteratura russa” (in due volumi) edita da Carocci, che differenza con le altre opere?
Lei è autore di “Storia della letteratura russa” (in due volumi) edita da Carocci, che differenza con le altre opere?
Mettendo mano alla Storia della letteratura russa ho coronato un sogno che mi portavo dietro da quando ero studente: scrivere un’opera complessiva che riportasse i frutti migliori degli specialisti di ogni epoca e di ogni autore, inserendoli in un orizzonte complessivo, in una narrazione “forte”. Del resto, è questo che differenzia una storia da un’enciclopedia letteraria: se questa basta a fornire un buon sunto bio-bibliografico su ogni autore, una storia conferisce ai singoli fenomeni una sorta di “terza dimensione”, li spiega come anelli di una complessa catena evolutiva, come tentativo di risolvere infiniti problemi stilistici, ideologici, di genere letterario, di intreccio, e al contempo come snodo problematico che pone altrettanti problemi per il futuro.
Un’opera del genere, a mio parere, dev’essere frutto di un solo studioso, capace di reggere le fila di tutti i processi storico-letterari nella loro interazione. Le vecchie storie di Ettore Lo Gatto o di Dmitrij Mirskij, pionieristiche al tempo loro, sono oggi inevitabilmente obsolete, inservibili: troppo veloce da allora è stato lo sviluppo della nostra disciplina, specie in Italia. Per quanto riguarda le storie Einaudi e Utet, uscite fra la fine degli anni Ottanta e la metà dei Novanta, sono sillogi di autori diversi, con sezioni buone e altre meno buone, ma in generale prive di un qualsivoglia orizzonte comune. Ma non è un problema solo italiano: una storia generale, organica della letteratura russa dalle origini ad oggi scritta da un solo autore in tempi più o meno recenti, semplicemente, non esiste in alcuna lingua, non esclusa quella russa. Diciamo che non è esattamente il tipo di opera che viene incoraggiato dalle tabelle ministeriali: a fini concorsuali, meglio centocinquanta articoli tutti sullo stesso minore del Seicento, e c’è pure meno da spremersi le meningi!
buone, ma in generale prive di un qualsivoglia orizzonte comune. Ma non è un problema solo italiano: una storia generale, organica della letteratura russa dalle origini ad oggi scritta da un solo autore in tempi più o meno recenti, semplicemente, non esiste in alcuna lingua, non esclusa quella russa. Diciamo che non è esattamente il tipo di opera che viene incoraggiato dalle tabelle ministeriali: a fini concorsuali, meglio centocinquanta articoli tutti sullo stesso minore del Seicento, e c’è pure meno da spremersi le meningi!
Quanto a me, a parte la forte motivazione e – diciamo – una certa faccia tosta, ho avuto il vantaggio di lavorare alla mia Storia negli anni 2000, un periodo di forte avanzamento degli studi, che ha toccato tutte le epoche storico-letterarie: io (senza certo trascurare i classici della disciplina) ero personalmente in stretto contatto coi collettivi di giovani studiosi che in Russia stavano lavorando alle varie epoche, e ho potuto così tentare di operare una sintesi complessiva del meglio che tale ondata di rinnovamento ha offerto: una sorta di monumento allo Sturm und Drang filologico della nostra gioventù, se si vuole… Poi, certo, oggi molte cose le formulerei diversamente, eviterei certe pesantezze, ma tre lustri fa ero meno esperto ed ero molto preoccupato di lasciarmi sfuggire qualcosa, di dare adito a critiche, e poi pensavo che se non avessi scritto tutto – ma proprio tutto – un’occasione così non si sarebbe più ripresentata.
Le magnificenze della letteratura russa a cui i grandi padri letterari ci hanno abituato hanno degli epigoni, degli eredi?
Credo di avere implicitamente già risposto a questa domanda. No: non ci possono essere eredi per chi raccontava quella comunità di destino, perché è essa stessa, con la sua proiezione in un immaginario universalistico, che non esiste più.
Sarebbe come chiedere a noi di ridare – non dico Dante, ma diciamo Leopardi: un Leopardi, un Puškin redivivi, di quali conflitti epocali potrebbero parlare? Oggi uno Shakespeare, un Dostoevskij, quali grandi snodi nel cammino dell’autocoscienza umana potrebbero narrare? Suvvia… Oggi, da noi come da loro, è tutto business: una catena di montaggio che ti impacchetta e ti mette per una settimana sul bancone di entrata della libreria, fra la marchetta al politico di turno e le ricette di Suor Germana!
Per quanto riguarda gli autori contemporanei, concordo col mio amico Oleg Lekmanov, valente studioso di Mandel’štam, che recentemente ha detto di dividerli in due gruppi: quelli di cui si percepisce più o meno il motivo per cui scrivono, l’impulso che li ha spinti a prendere la penna in mano, e quelli – la grande maggioranza! – che proprio non si capisce perché si siano messi a scrivere, data la sensazione, leggendoli, che stiano espletando un compitino d’esame odioso a loro stessi per primi.
E come viene raccontato il territorio, il legame con la madre Russia, in narrativa?
Su questo punto, un cambiamento interessante avviene nella prosa degli anni Venti, perché dopo la Rivoluzione cambia proprio il cronotopo di riferimento: non più il trinomio metropoli-cittadina-villaggio (con tutte le implicazioni in termini di proiezione storica “ottocentesca” e nobiliare-terriera), ma una Russia remota, luogo di confine, commistione “senza tempo” di Oriente e Occidente. Per Boris Pil’njak, ad esempio, si tratta del bacino del fiume Oka, sede delle più antiche città russe ma aperto verso il Caspio e la Via della Seta tramite lo sbocco nella Volga: un sistema ad anelli col centro nel quartiere moscovita Kitaj-Gorod (dall’evocativa pseudo-etimologia: «Città cinese») fino all’estremo ampliamento “eurasiatico” nel triangolo Uglič – Brugge – Kamakura (vedi i suoi romanzi L’anno nudo e Mogano). Per l’Isaak Babel’ dell’Armata a cavallo si tratta delle regioni fra Russia e Polonia, con un ulteriore elemento – quello ebraico – che sperimenta sulla propria pelle la condizione del “terzo incomodo”. Nel Treno blindato 14-69 di Vsevolod Ivanov si tratta invece dell’Estremo Oriente siberiano, fra partigiani russi e cinesi, militari giapponesi e strane comunità dall’aspetto antidiluviano. E ancora – Don cosacco, Caucaso, Volga, Siberia, spesso seguendo i fronti della tragedia epocale appena terminata.
Detto questo, secondo me a livello di rapporto viscerale con la terra natia, se la battono Šolochov e Pasternak: il primo dipinge una natura meridionale, rigogliosa, panica, immediata con grasse pennellate piene di carnalità e di gioia di vivere benché Il Placido Don sia un cupo miserere sulla fine di un’intera civiltà; quanto al Dottor Živago , è una natura simbolizzata, trasfigurata come una membrana dietro a cui in controluce baluginano gli Eterni. Sta alla sensibilità del lettore scegliere, quantunque ci si trovi in ogni caso ai massimi livelli.
In seguito, l’atteggiamento verso il territorio viene a dipendere molto dalla posizione anche ideologica dello scrittore. Negli anni Sessanta-Settenta si confrontano una prosa “urbana”, giovanile, orientata, fra l’altro, su Salinger, e una prosa ruralista dove la perdita della Russia “tradizionale” è l’evento tragico centrale: si descrivono kolchoz scalcinati, cittadine e villaggi senza futuro, e qui, spesso, l’autore occidentale di riferimento è Faulkner. In molti autori c’è anche una certa dose di esotismo (ovviamente sovietico), di gusto per l’avventura, per il viaggio senza meta: un mood frutto del grande amore che la generazione di quegli anni aveva per Hemingway.
Oggi la provincia viene molto raccontata: le metropoli, coi loro ritmi frenetici e il mainstream globalizzato, hanno stufato, e col lento ma costante miglioramento delle condizioni di vita, le regioni stanno lentamente imparando a narrare se stesse. Del resto, la Russia è un arcipelago di popoli, culture, storie ora condivise ora gelosamente preservate: chi conosce solo Mosca e Pietroburgo non sa nulla della Russia.
Cosa dire della poesia? Cosa non conosciamo in Italia e perché?
Domanda difficile, se non si vuole rispondere in modo semplicistico. La poesia russa del Novecento, in buona sostanza, è figlia dell’annus mirabilis 1921-22, quando, per parafrasare Gianfranco Contini, Rivoluzione e guerra civile “salano il sangue” ai poeti più giovani (a prescindere dalle posizioni ideologiche di ognuno) e avviene una sorta di big bang che rivoluziona il settore: escono cicli e raccolte fondamentali (alcune scritte qualche anno prima, come Mia sorella la vita di Pasternak) che rompono definitivamente la configurazione degli anni 1900-1910, ossia l’egemonia a tratti un po’ pacchiana di simbolismo e dintorni. In quel biennio si definisce la gerarchia poetica dei decenni a venire, sia metropolitana che dell’emigrazione: chi consolida una posizione di “asso” che aveva iniziato a definirsi già negli anni precedenti (Achmatova, Chlebnikov, Gumilëv, Majakovskij), chi si accredita ora come stella di prima grandezza (Cvetaeva, Esenin, Mandel’štam, Chodasevič, Pasternak). E naturalmente ci sono gli esordienti: in particolare Konstantin Vaginov, e poi Georgij Adamovič, Nikolaj Ocup, ossia i poeti “neoclassici” che daranno il meglio di sé in emigrazione (anche se le vette poetiche della poesia émigré fra le due guerre, a mio parere, sono il surrealista Boris Poplavskij e il minimalista e dolente Georgij Ivanov). Nel 1921-22 i giochi della poesia russa novecentesca sono fatti: poco altro si aggiungerà in seguito alla gerarchia che in questo giro di mesi si va formando.
Ciò naturalmente non significa che non vi siano in seguito forti scosse di assestamento, dovute anche al controverso rapporto dei poeti con una realtà politica e sociale in continua evoluzione. Tanto per cominciare, verso la metà degli anni Venti i principali poeti di quella generazione abbandonano temporaneamente la lirica per dedicarsi alla prosa (con autentici capolavori) a forme poetiche più lunghe e strutturate: un’epica dotata di trama storica in Pasternak (Sublime malattia, i poemi degli anni Venti), la riattivazione del genere odico-metafisico settecentesco in Mandel’štam (L’ode d’ardesia, Colui che trova un ferro di cavallo), il poema cosmico-esistenzialista in Cvetaeva (Il prode, Poema della montagna, Poema della fine). È un fenomeno che si può interpretare come reazione a un ancor insufficiente radicamento dei principali poeti nella nuova “ecologia linguistica” nata dalla Rivoluzione e dagli smottamenti sociali da essa originati: i lirici ci metteranno un po’ per fare propria questa nuova lingua e innescare nuovamente i processi di aggregazione microstilistica a un livello sufficiente di profondità e complessità per fare lirica. Alcuni di loro, peraltro, non abbandoneranno mai le grandi forme, come nel caso di Mandel’štam con la sua ultima e oscurissima epopea dei Versi sul milite ignoto (1937), «un oratorio in onore del vero ventesimo secolo» purtroppo poco noto da noi: in generale, la poesia russa novecentesca delle grandi forme è stata tradotta male, da slavisti anche di spessore, ma che ritenevano sufficiente un’immediata adesione empatica e, spesso, una certo arbitrio traduttivo. Ma con testi così complessi non funziona: bisogna avere un po’ di umiltà, per prima cosa sforzarsi di capire di cosa esattamente si stia parlando…
Intanto, fra la fine degli anni Venti e la prima metà degli anni Trenta, si verifica un fenomeno che avrà notevoli ripercussioni nella poesia russa: il mainstream “ufficiale” è retorico, ripetitivo e di fattura sempre più dozzinale, mentre attraverso canali informali si diffondono nuove correnti sperimentali, tipologicamente assimilabili al coevo surrealismo. Sono i poeti che ruotano attorno al gruppo “Oberiu”: Daniil Charms, Aleksandr Vvedenskij, Nikolaj Zabolockij, Nikolaj Olejnikov (abbondanti materiali su Oberiu e traduzioni di testi poetici si possono trovare in: “eSamizdat”, 2007, n. V 1-2 ). Inizialmente molto radicali, negli anni trenta alcuni di loro vireranno verso una sorta di “classicismo metafisico” dove la vena assurdista è spinta come sottotraccia. Nasce così una linea di sviluppo sotterranea che nel Dopoguerra, durante il cosiddetto Disgelo, porterà a una sorta di “doppio canale”: in superficie abbiamo i “poeti tribuni” Evtušenko, Voznesenskij, Achmadulina, etc., molto popolari presso il pubblico di massa (a dispetto di una certa superficialità e del valore disuguale dei versi), perché danno voce alle problematiche del tempo; nel frattempo, come tendenza di lungo periodo al momento invisibile ai più, si afferma un’assai vivace “neoavanguardia” poetica legata con mille fili nascosti alle propaggini dei non poi troppo lontani anni Trenta: tale neoavanguardia fa da ponte alle tendenze successive, che saliranno alla ribalta al crepuscolo del periodo sovietico. Il minimalismo antiestetico dei poeti moscoviti influirà sulla nascita del concettualismo degli anni Settanta-Ottanta, mentre a Leningrado da una parte si delinea il “neoacmeismo” di Iosif Brodskij – dedito a opere di taglio narrativo che spesso assumono i contorni dell’ode civile e della meditazione sulla storia – e dall’altra Leonid Aronzon recupera il “neoclassicismo” ermetico tardo-oberiuta, facendo da ponte alla poesia metafisica e spiritualista leningradese degli decenni seguenti.
L’ultima grande stagione poetica russa, quella degli anni Settanta-Ottanta, presenta dunque una vena moscovita, neoavanguardista, improntata all’assurdismo postmodernista (Dmitrij Prigov, Lev Rubinštejn, Timur Kibirov), e una leningradese, metafisica e spesso misticheggiante: qui il fenomeno centrale è certo Elena Schwarz, a mio parere la più bella voce poetica russa dell’ultimo quarto di secolo, purtroppo mancata nel 2010. Una donna semplice, sincera, pervasa di un’immediata e genuina carica visionaria. Al lettore italiano questo patrimonio è stato reso acessibile da instancabili traduttori quali Massimo Maurizio (più sul versante neoavanguardistico), Marco Sabbatini e Paolo Galvagni (su quello metafisico-spiritualista): consiglio senz’altro di procurarsi le edizioni da loro curate, così come quelle di Alessandro Niero.
Purtroppo, il panorama contemporaneo non offre più prove di quel livello. Non che manchino validi poeti, ma oggi la poesia – ancor più della letteratura “colta” in generale – è confinata in una nicchia molto ristretta, dove i testi circolano fra pochi cultori. Un fenomeno che suscita simpatia è certo il ruolo dominante svolto dalle autrici: pur se molto diverse per età, temperamento e livello, Marija Stepanova, Linor Goralik, Elena Fanajlova, Evgenija Lavut, Polina Barskova, Aleksandra Cibulja, Vera Polozkova conferiscono alla poesia russa contemporanea uno spiccato carattere femminile.
Guido Carpi (1968) è ordinario di Letteratura russa all’Università di Napoli “L’Orientale”, è autore di numerosi articoli e monografie, fra cui: “Dostoevskij economista” (Mosca 2013. In lingua russa), “Storia del marxismo russo” (Mosca 2016. In lingua russa), “Storia della letteratura russa” (Roma 2016, due voll.), “Russia 1917. Un anno rivoluzionario” (Roma 2017). Ha curato un’antologia di poesie di Vladimir Majakovskij (Milano 2008). Molti suoi interventi sono pubblicati sul suo canale youtube.


